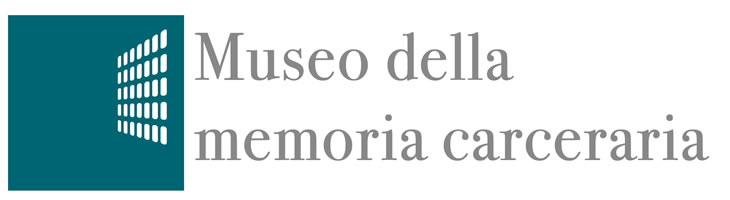I quarant’anni da sorvegliante di Francesco Maisto
Un professore di Sociologia del Diritto, Claudio Sarzotti, e un magistrato, Francesco Maisto, discutono dell’esecuzione penale e della funzione della magistratura di sorveglianza a quarant’anni dal varo dell’Ordinamento Penitenziario

Francesco Maisto è uno di quei giudici che hanno fatto la storia della magistratura di sorveglianza in Italia. Nel dicembre scorso è andato a riposo e abbiamo voluto fare con lui una breve chiacchierata per rievocare alcuni aspetti di quella storia. Questo è il resoconto della conversazione che abbiamo avuto con lui.
a cura di Claudio Sarzotti
Come sei entrato in contatto con il lavoro di magistrato nell’ambito dell’esecuzione penale?
Entrai in magistratura di sorveglianza nel 1980, quindi qualche anno più tardi della riforma, in quanto prima svolsi le funzioni di Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Milano e in seguito di Giudice Istruttore presso il Tribunale di Napoli. Eravamo ai primordi della magistratura di sorveglianza e nella cultura professionale dei giudici non c’era la percezione di svolgere una vera e propria attività giurisdizionale. Ricordo le prime ordinanze dei magistrati di sorveglianza: sembravano provvedimenti amministrativi, la motivazione e l’argomentazione giuridica era pressoché inesistente. Le riviste giuridiche non pubblicavano quelle ordinanze perché erano irrilevanti rispetto alla dottrina giuridica. Le prime note a sentenza furono quelle di Giuseppe La Greca e del sottoscritto sul Foro Italiano. In una seconda fase, un’altra rivista che ospitò quelle prime riflessioni in materia di diritto penitenziario fu quella del Ministero della Giustizia, la Rassegna penitenziaria e criminologica. Del resto neanche l’università si interessava all’insegnamento di quella branca di diritto considerata poco interessante perché priva di un contenuto scientifico. Il primo corso di diritto dell’esecuzione penale è stato quello di Vittorio Grevi presso l’Università di Pavia proprio nell’anno della riforma ed è stato recentemente ricordato con un convegno in quell’università in occasione del quarantennale. Anche il gruppo dei magistrati di sorveglianza era di piccole dimensioni e seguivamo grandi maestri come …
Che rapporti avevate con il mondo del carcere, con gli operatori penitenziari, i direttori degli istituti? Andavate spesso in carcere?
Si trattava di relazioni per nulla burocratizzate, molti informali, soprattutto con gli educatori e gli assistenti sociali del Ministero della Giustizia. Avevamo instaurato rapporti proficui anche con le associazioni di volontariato, che allora erano abbastanza rare e non avevano ancora subito l’attuale proliferazione. C’era anche un informale scambio di dati che ci consentivano di conoscere meglio i soggetti condannati e le loro effettive personalità integrando le informazioni che si potevano desumere dalle carte processuali. Volendo distinguere una prima fase nella storia della magistratura di sorveglianza, che potrebbe essere quantificata in circa un quindicennio, vale a dire fino ha qualche anno dopo la legge Gozzini, i rapporti con l’istituzione penitenziaria sono stati rapporti per così dire di massima intrusione. Pur preservando l’indipendenza e l’esclusiva soggezione alla legge, i magistrati di sorveglianza crearono ad esempio rapporti con i direttori degli istituti che erano quasi necessitati e naturali in quanto molta della loro attività si svolgeva fisicamente in carcere. C’erano delle sezioni di alcuni Tribunali di sorveglianza che svolgevano le loro udienze all’interno degli istituti. Le visite e i colloqui in carcere con i detenuti avevano frequenza settimanale; colloqui ai quali si accompagnavano le chiacchierate all’ingresso con gli educatori e gli assistenti sociali. E con i direttori. Erano rapporti per nulla burocratici. Se il detenuto lamentava che gli era stato somministrato un farmaco scaduto o diverso da quello richiesto, ricordo che si usciva dalla sala colloqui, si chiamava il direttore e si verificava immediatamente l’istanza. Alcuni direttori rimanevano fedeli al loro mandato e collaboravano, altri si arroccavano sulle loro posizioni e non gradivano quelle interferenze adottando un comportamento più burocratico. Verso questi ultimi non destava meraviglia che ogni tanto qualche magistrato potesse preparare quelli che si chiamavano rapporti giudiziari da inviare alla Procura della Repubblica, ovvero notizie di reato a carico dei direttori stessi. Ma nella maggior parte dei casi i rapporti erano positivi. I rapporti conflittuali riguardavano soprattutto quel traghettamento dell’istituzione penitenziaria da un’isola di illegalità e di impunità ad un luogo che rispondesse alla legalità repubblicana e costituzionale che era stato l’obiettivo principale della riforma. Mi ricordo quando ispezionammo i sotterranei di San Vittore dove i detenuti lavoranti effettuavano le loro attività senza alcuna assicurazione contro gli infortuni e con macroscopiche violazioni della normativa anti-infortunistica.
Hai avuto l’impressione che la riforma del 1975 cadesse in una cultura giuridica non pronta a recepire quel tipo di messaggio normativo?
Certamente la cultura della magistratura in generale, dell’accademia e dell’opinione pubblica non lo erano. Basti pensare agli immediati provvedimenti disciplinari subiti dai magistrati di sorveglianza dell’epoca per le evasioni di alcuni detenuti in permesso premio. Si trattava, come dimostrò una indagine statistica del Consiglio Superiore della Magistratura a livello europeo, di percentuali molto basse e assolutamente in linea con quelle degli altri Paesi europei, ma i procedimenti partirono ugualmente anche se molti finirono con assoluzioni. Credo invece che l’istituzione penitenziaria in generale sia stata molto più recettiva perché capiva che la riforma penitenziaria sarebbe stata non soltanto una valvola di sfogo per i detenuti, ma che avrebbe comportato un cambiamento in positivo dell’immagine pubblica degli operatori penitenziari. Non sarebbero più stati solamente coloro che aprivano e chiudevano le celle.
Quindi i problemi maggiori sono arrivati dalla società esterna al carcere? Una delle richieste che durante le rivolte degli anni ‘70 facevano sempre i detenuti era quella di coinvolgere la stampa e di riuscire far passare le informazioni alla opinione pubblica. Come magistrati di sorveglianza avete cercato di sensibilizzare gli organi di informazione?
I detenuti quando facevano le rivolte e le proteste, sia collettive che individuali, non chiamavano solamente la stampa, ma anche i giudici di sorveglianza. Quindi noi c’eravamo sempre. Allora non c’erano i telefoni cellulari, ricordo che abitavo non molto lontano da San Vittore e il mio telefono fisso squillava spesso anche nella notte. La Questura aveva a disposizione il numero del ristorante in cui mi recavo a cena. All’epoca in molti istituti penitenziari, tra cui San Vittore, c’erano le cosiddette bocche di lupo. Dei finestroni che non davano la possibilità di vedere dall’esterno, ma che consentivano solo il passaggio dell’aria e della luce. Proprio come una bocca di lupo aperta. Ricordo che ne feci buttar giù tutte con un investimento anche finanziario dell’amministrazione non certo irrilevante. Il detenuto che non riusciva ad ottenere una telefonata o un colloquio si infilava in una bocca di lupo e minacciava di non scendere e di buttarsi giù. Ricordo che eravamo spesso nella intercinta di San Vittore con i pompieri e i teloni pronti a raccogliere coloro che minacciavano di lanciarsi.
La riforma, come racconta Christian De Vito nel lavoro più completo sulla storia del carcere nell’Italia repubblicana, è stata il frutto dello spirito riformatore degli anni ’60, ma venne emanata in un clima politico-culturale cha aveva preso direzioni diverse con gli incombenti anni del terrorismo?
Le prime restrizioni alla riforma avvennero già nel 1977 con una limitazione normativa rispetto alla concessione delle misure alternative. Ma ancora più rilevante fu la costituzione delle sezioni di massima sicurezza e delle carceri di massima sicurezza sotto la direzione dell’Arma dei Carabinieri del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. In queste carceri veniva applicato l’articolo 90 che in pratica sospendeva, per ragioni di ordine e sicurezza, l’attuazione della riforma. Il Ministero applicò addirittura degli articoli 90 nominativi ovvero non ad interi istituti penitenziari come prevedeva la riforma, ma a singoli detenuti. Ricordo che riuscimmo a far annullare quel provvedimento per le detenute della sezione femminile di San Vittore. L’estendersi del regime di massima sicurezza attrasse come una calamita i regimi detentivi di tutti gli altri istituti di pena. La massima sicurezza trainava tutto il sistema verso una maggiore rigidità. In ciò la politica penitenziaria convergeva con la politica della lotta armata perché quest’ultima era contraria alla cosiddetta differenziazione dei circuiti penitenziari.
Hai avuto modo di venire a contatto anche con detenuti politici?
Anche l’interazione con i politici era necessitata perché chiedevano del magistrato di sorveglianza o di un parlamentare di cui si fidavano. Le proteste talvolta erano violente. Mettevano a fuoco le suppellettili dei raggi, salivano sui tetti per protesta o facevano il cosiddetto salto del bancone nelle sale colloqui, la protesta per l’affettività. I leader della protesta ebbero un effetto trainante non soltanto in relazione alla protesta degli altri detenuti comuni, ma anche a quel rapporto con il decisore politico che oggi purtroppo non esiste più. Mi riferisco al fatto che “il carcere dei politici” divenne un luogo di elaborazione e riflessione in merito ai rapporti tra carcere e società, contribuendo a quella revisione della riforma penitenziaria che si concretizzò in seguito con la legge Gozzini. Dopo una prima fase di scontro, i detenuti politici, tranne gli irriducibili, contribuirono al mutamento del sistema carcere. Il cambiamento avvenne con la costituzione delle cosiddette aree omogenee. Si chiamavano così perché erano costituite da detenuti che avevano una posizione comune rispetto alla lotta armata e avevano instaurato un rapporto di legittimazione reciproca con un determinato soggetto politico che poteva andare dalla Caritas ambrosiana al partito comunista. Non erano pentiti, collaboratori di giustizia, ma dissociati, soggetti che riconoscevano che la lotta armata non era più praticabile e davano chiara testimonianza di non ritenere più praticabile quella linea politica efferata e violenta. Ricordo quando tutti i “politici” erano concentrati al carcere sardo di Badu ‘e Carros, compresa la direzione strategica delle BR, e alcuni parlamentari della Sinistra Indipendente ci chiesero, come magistrati di sorveglianza, di andarli a visitare per poterli riportare in istituti della penisola. Allora vennero costituite le aree omogenee di Rebibbia, di San Vittore e di Bergamo. Quelle aree produssero una quantità di documenti. Quella di San Vittore produsse una serie di documenti e richieste che confluirono nella legge Gozzini sull’affettività, sul lavoro all’interno degli istituti e sui rapporti con il volontariato. Questi documenti furono il frutto di un apporto molto positivo anche di soggetti autorevoli della cultura e della Chiesa. Per esempio qui a San vittore penso al gruppo della Nuova Corsia dei Servi di Mario Cuminetti e ad altri personaggi come padre Davide Turoldo, padre Camillo de Diaz. Mi ricordo che autorizzai Rossana Rossanda ad andare a San vittore. Entravano ogni settimana per tenere seminari una grande quantità di soggetti autorevoli del mondo della cultura del sindacato, psico-pedagocisti etc.
Sono passati trent’anni da quell’epoca ma ne sembrano passati molti di più? Il mondo di oggi non ha conservato memoria di queste attività. Quando si è prodotta una rottura rispetto a questo mondo? Sia la riforma del 1975 sia la legge Gozzini hanno avuto come spinta le richieste della popolazione detenuta. Oggi tutto questo sembra impossibile.
Sembra impossibile però bisogna ricordare che c’è stata un’epoca in cui non si parlava di sorveglianza dinamica ma che tuttavia era contrassegnata dalle celle aperte tutta la giornata, la libertà di movimento all’interno della sezione era totale. La spinta arrivava anche dagli enti locali, in particolare le amministrazioni di sinistra e quelle da democristiani illuminati, non democristiani di casta ma cattolici veramente credenti. La rottura credo si sia prodotta purtroppo con la strage di Capaci nel 1991-1992. Nella storia del sistema penale italiano ogni qualvolta c’è stato qualche gravissimo evento traumatico si è andato immediatamente a stringere sull’anello più debole del sistema. La politica criminale italiana è stata sempre estremamente oscillante, mai chiara e ferma. E quindi per l’immagine pubblica si è mostrata una maggiore severità nei confronti dei detenuti. Basti pensare che dopo la strage di Capaci con il decreto Martelli ci fu una restrizione delle misure alternative; tutti quelli che da anni erano in semilibertà furono riportati in carcere e rinchiusi. Nonostante non avessero commesso alcun reato. Poi intervenne, su sollecitazione della magistratura di sorveglianza, la Corte costituzionale, ma dopo molti anni. Quindi fu più influente l’emergenza mafia di quanto non sia stata l’emergenza terrorismo. In tal modo, il profilo del recluso è cambiato; sono entrati più detenuti per fatti di criminalità organizzata. E con i migranti si è passati in seguito al carcere multietnico. Questi fenomeni hanno modificato il lavoro del magistrato di sorveglianza soprattutto nell’approccio. Ci sono a volte problemi di comunicazione, ci può essere una certa ritrosia da parte della magistratura di sorveglianza a concedere le misure alternative a persone che a volte non si riesce a conoscere. Un altro grande cambiamento si è verificato nel periodo di Mani Pulite. In quell’epoca non facevo il magistrato di sorveglianza, ero alla Procura generale di Milano, ma frequentavo le carceri come volontario. Mani pulite ha segnato una svolta nel senso che l’incarcerazione di un certo numero di persone per le quali il carcere non era nato, cioè i politici di professione, i portaborse, i colletti bianchi etc., hanno portato ad un interessamento da parte della politica della vita all’interno degli istituti e quindi ad un tentativo civilizzare e umanizzare la pena.
Un po’ come era avvenuto nella assemblea costituente quando l’articolo 27 venne discusso da molti padri costituenti che avevano conosciuto le carceri fasciste. In queste settimane è uscito il bel libro di Elvio Fassone Fine pena: ora (Sellerio Editore) che narra della sua corrispondenza pluridecennale con un ergastolano; ti è mai capitato di avere un rapporto simile con un detenuto?
Di Fassone ricordo il suo volume monografico sulla pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma del 1975 e il suo impegno per i magistrati di sorveglianza quando sedeva nel Consiglio Superiore della Magistratura. Si era dato da fare per la commissione mista dei magistrati di sorveglianza e come parlamentare ha lavorato ad ogni legge riguardante il sistema penale. Come giudice ha sempre avuto questa grande sensibilità al tema pena. Io ho ancora oggi buoni rapporti con persone che furono ristrette negli anni di piombo ed oggi lavorano nel settore del volontariato o si occupano del recupero dei tossicodipendenti. Per esempio, con i cosiddetti due Sergio, Segio e Cusani, che hanno svolto una importante attività tesa a civilizzare l’istituzione penitenziaria. Ci sono alcuni di quelli della lotta armata che hanno partecipato alle attività del gruppo Cuminetti: Francesco Bellosi, Franco Bonisoli, che faceva parte della direzione delle Br, altre persone di Prima Linea. Persone che non hanno avuto difficoltà anche nei dibattiti pubblici a stare allo stesso tavolo di magistrati. Può succedere di mantenere relazioni anche con detenuti comuni, ma in genere, nella mia esperienza, scontata la pena non si sono esposti per migliorare le condizioni del carcere. Talvolta mi emoziono e mi commuovo quando, in qualche mercato di Milano, rivedo tra gli ambulanti ex detenuti. Per lo più sono persone che al massimo ti chiedono se mi ricordo di loro e io non rispondo subito, perché non vorrei che pensassero che me li ricordo solamente perché erano carcerati. Poi ci sono persone che continuano a scriverti auguri di Natale a distanza di anni, magari sbagliando l’indirizzo. Non ho una corrispondenza continua con nessuno di loro anche perché non la potevo avere sino a quando ero magistrato in carica. Ricordo che Galante Garrone, che è stato sempre molto vicino alla magistratura di sorveglianza, andava spesso in carcere e aveva corrispondenze epistolari con detenuti e loro parenti, ma diceva spesso: “meno male che sono parlamentare, perché da alcune lettere potrebbe apparire qualche tipo di compromissione”. Si tratta di un crinale molto delicato.
Se dovessi descrivere ad un magistrato di oggi le principali differenze che intercorrono tra la tua epoca è quella odierna che cosa potresti dire?
Gli chiederei innanzitutto se ha voglia di fare un lavoro difficile e di continuare ad essere giudice, ovvero di esercitare la giurisdizione dei diritti sanciti dalla legge per i detenuti. Sono stato sempre contrario alla magistratura di sorveglianza a vita, nel senso che una delle cose positive del nostro ordinamento è la possibilità di cambiare ruolo. Credo che il magistrato di sorveglianza e quello minorile svolti per troppo tempo e con intensità determinino burn out per il troppo coinvolgimento. È sempre bene prendere un po’ d’aria ogni tanto, staccare e magari riprendere. E questo ho cercato di fare. Oggi, il lavoro del magistrato di sorveglianza espone a rischi. È un lavoro “senza rete” nel senso che ti espone a rischi, non tanto per la tua vita, anche se ci sono state delle epoche in cui i magistrati di sorveglianza, e io stesso, hanno rischiato, sia nel periodo della lotta armata che della criminalità organizzata. Il rischio che si corre oggi è quello di non essere valorizzati dalla stessa istituzione giudiziaria e dai giudici che lavorano al Ministero per la qualità del lavoro che si fa. Secondo me, il magistrato di sorveglianza viene ancora oggi percepito come un magistrato di serie B nonostante tutti gli sforzi che si sono fatti. C’è, a tal proposito, anche un difetto nella formazione dei magistrati sorveglianza. Non si fa capire fino in fondo quanto essa, pur essendo una giurisdizione particolare, sia sempre una giurisdizione a tutto tondo. E quindi che si deve rimanere estranei alla amministrazione. Questo non significa scontro continuo e permanente, ma il giudice è giudice e l’amministrazione fa parte dell’esecutivo. Inoltre spesso si ritiene che per essere giudici di sorveglianza si debba essere fuori e lontani dal carcere in modo da non farsi condizionare: “mi metto fuori per mettermi sopra”. Questa è una visione sbagliata perché chi fa il magistrato di sorveglianza per vocazione e ha le spalle quadrate deve essere “al fianco”. Ho sempre detto agli uditori che bisogna trattare con i detenuti e con gli operatori seguendo il motto evangelico: “il vostro parlare sia sì sì, no no”. I carcerati hanno sempre stimato il giudice che quando va in carcere, con grande lealtà e senza essere vile, non fa false promesse, le promesse di Pinocchio. Bisogna avere il coraggio di dire no. È un atteggiamento rischioso, ma credo che la maggioranza dei carcerati l’abbia sempre apprezzato, la chiarezza prima di tutto.
La cultura del magistrato molte volte tende a non essere coinvolta negli interventi cosiddetti di rete che invece implicano un coinvolgimento di tutti i soggetti che collaborano ai percorsi di reinserimento dei condannati. L’essere coinvolti e mantenere il grado di indipendenza: è forse la cosa più difficile per il magistrato?
Il mestiere di magistrato di sorveglianza è tra quelli più complessi esistenti nel nostro ordinamento. Credo tuttavia che esistano alcune pratiche virtuose che ci insegnano, direi in maniera quasi scientifica, come sia possibile fare il lavoro di rete pur rimanendo soggetti solamente alla legge. Non lo affermo in astratto, ma per esperienza diretta: per esempio, in relazione alle misure alternative per le persone tossicodipendenti a Bologna ho firmato protocolli di intesa tra Tribunale di sorveglianza e Ser.T. per elaborare insieme un comune linguaggio, comuni categorie di pensiero e modalità più agevoli per gestire le misure alternative. Rimane in questi casi sempre uno spazio di discrezionalità riservato al magistrato, ma questa discrezionalità non è autoritaria, arbitraria, ma diventa una discrezionalità all’interno di un contorno definito. Altrettanto ho fatto per la chiusura dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario e per l’apertura delle cd. REMS. Credo che una buona premessa per il lavoro di rete sia quello dei protocolli di intesa che richiedono una capacità di contaminare le categorie giuridiche con gli altri statuti professionali delle altre scienze non giuridiche. Credo sarebbe necessario che la magistratura di sorveglianza accogliesse come elementi non spuri dell’ordinamento il rapporto con tali scienze. Per esempio, considero negativamente le ultime norme che hanno previsto i provvedimenti interinali e provvisori che vengono concessi dal magistrato in veste monocratica per ridurre i tempi della giustizia. È vero che il monocratico è più veloce del collegiale, ma sarebbe stata sufficiente una delibera del Consiglio Superiore che stabilisse la priorità per i processi con persone detenute, quando ancora oggi in molti Tribunali di sorveglianza si fissano le udienze in base ai numeri di ruolo. Questi provvedimenti interinali influiscono negativamente sulla giurisdizione perché sono provvedimenti decisi solo dal magistrato di sorveglianza con la sua cultura giuridica e in seguito difficilmente sono riesaminati da parte del collegio. Il collegio è fondamentale perché al suo interno c’è il contributo dell’esperto, dello psicologo, dello psichiatra, del pedagogista; questi esperti non servono per fare beneficenza, non servono solo per rendere umana la pena, ma contribuiscono alla decisione con il loro sapere.
Tra i fenomeni secondo me più inquietanti degli ultimi anni si è assistito ad una sorta di rimilitarizzazione della polizia penitenziaria in seguito all’abolizione dell’obbligo del servizio di leva. Che ne pensi?
La polizia penitenziaria nella storia del carcere italiano si è evoluta molto. Penso ai giovani laureati neoassunti e a tanto personale di polizia penitenziaria attento e sensibile. Se ci fosse una formazione adeguata e selettiva dei commissari di polizia penitenziaria non sarei contrario neanche alla loro direzione di istituti penitenziari in cui non fossero particolarmente pressanti le esigenze di reinserimento sociale. Ciò che mi preoccupa di più invece è questo fenomeno di persone che vengono dapprima distaccate in carcere dall’esercito o persone che lasciano l’Arma dei Carabinieri ed entrano in polizia penitenziaria. Inevitabilmente, almeno in una prima fase di lavoro, sono agenti che possono provocare degli arretramenti, un irrigidimento del sistema. I militari che tornano dall’Afghanistan e vanno in polizia penitenziaria creano inevitabilmente dei problemi dal punto di vista delle attività trattamentali. A prescindere dalla loro volontà individuale. A mio parere, c’è un’ultima considerazione da fare: questa arlecchinata oggi rappresentata dal nostro sistema penale e penitenziario non potrà reggere a lungo, è un abito vecchio troppo rattoppato. Gli Stati generali sull’esecuzione penale possono essere un ottimo volano per modificare completamente il sistema. Essi hanno già prodotto qualcosa che ancora non è emerso in superficie, ma che ha animato e superato l’eccessiva immobilità degli ultimi anni. Duecento esperti che discutono di carcere, si confrontano con l’università, vanno nelle carceri etc. modificano la cultura dell’opinione pubblica sul carcere e sulla pena. Qui a Milano, per effetto degli Stati generali, stanno entrando negli istituti molti professori universitari ed esperti di ogni tipo. Bisognerà che questo lavoro si trasformi in modo omogeneo e coerente in dettato normativo. Ma questo lo si può fare soltanto distruggendo l’abito vecchio. Sono molto scettico sull’attuale struttura ordinamentale dei Tribunale di sorveglianza: secondo me, bisognerebbe abolire gli uffici di sorveglianza e istituire un unico Tribunale di sorveglianza distrettuale come si sta facendo per il tribunale dei minori. Il mondo in cui viviamo e la geografia italiana è cambiata rispetto a quella del 1975. Uffici di sorveglianza con un unico magistrato di sorveglianza a che cosa servono? Sono tutti residui burocratici che rallentano complessivamente il sistema. Occorre una nuova sensibilità della cultura giuridica ai problemi organizzativi. Tale sensibilità era patrimonio anche dei vecchi presidenti di tribunale: personaggi come Alessandro Margara e Mario Canepa avevano molto chiaro il disegno organizzativo dei loro uffici giudiziari. Quello che invece non è chiaro ancora oggi sono i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti di sorveglianza. Occorre, così com’è stato fatto nelle Procure, che tali criteri vengano esplicitati nel piano organico organizzativo generale dei singoli Tribunali di Sorveglianza sottoposto all’approvazione del CSM. E all’interno del Consiglio stesso deve maturare una competenza specifica in materia di esecuzione penale. Non è possibile, come avviene oggi, che non ci sia tra i componenti togati eletti almeno un magistrato di sorveglianza, né tra gli accademici nominati qualcuno che insegni diritto penitenziario. Altrimenti sembra che i quarant’anni dalla riforma siano passati invano.
* Una versione ridotta di questo colloquio-intervista è stata pubblicata nell’ultimo Rapporto dell’Associazione Antigone: Galere d’Italia, XII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione.
SCARICA IL DOCUMENTO INTEGRALE IN VERSIONE .PDF